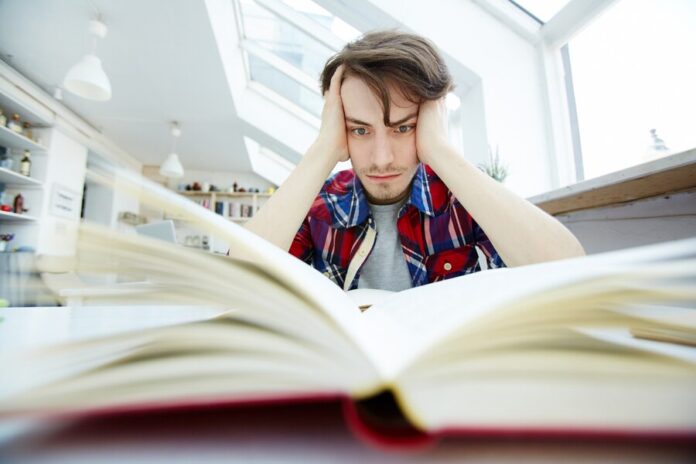L’effetto Flynn inverso segnala il declino cognitivo della nostra civiltà. Perdiamo progressivamente intelligenza. Perché sta accadendo?
L’inizio del nuovo millennio ha portato con sé una preoccupante inversione di tendenza nel panorama delle capacità cognitive umane: il declino del QI medio, un fenomeno noto come effetto Flynn inverso, che contraddice la crescita costante osservata per decenni, chiamata effetto Flynn. Quest’ultimo, descritto per la prima volta da James R. Flynn negli anni ’80, evidenziava un aumento medio di circa 3 punti di QI per decennio in molte nazioni industrializzate, a partire dal 1938 fino a circa il 1985. Questa crescita costante, osservata in diversi studi, ha portato a ipotizzare che fattori ambientali, come il miglioramento delle condizioni di vita e dell’alimentazione, giocassero un ruolo fondamentale nello sviluppo cognitivo.
Dal 1938 al 1985 il quoziente di intelligenza medio è aumentato costantemente di circa 3 punti ogni 10 anni. Poi il fenomeno si è invertito e non si è più arrestato: è declino cognitivo.

L’effetto Flynn inverso, invece, segnala un’inversione di tendenza. Studi condotti in Norvegia (Sundet et al., 2004), Danimarca (Teasdale & Owen, 2005) e Gran Bretagna (Flynn, 2009) hanno dimostrato un calo del QI medio a partire dagli anni ’90 e 2000. Diverse ipotesi sono state avanzate per spiegare questo fenomeno. Alcuni ricercatori hanno suggerito cause di natura disgenetica (Lynn & Harvey, 2008), ipotizzando un deterioramento del pool genetico legato all’intelligenza. Tale ipotesi, però, è stata successivamente confutata da studi che attribuiscono il declino a fattori ambientali (Bratsberg & Roberger, 2018).
Altri studi focalizzano l’attenzione su fattori ambientali, tra cui l’aumento dell’uso di videogiochi e internet, a scapito di attività cognitive più stimolanti come la lettura e la scrittura (Bratsberg & Roberger, 2018). Un’altra ipotesi, non in contraddizione con le precedenti, sostiene che i test del QI, progettati decenni fa, potrebbero non essere più adeguati a misurare le capacità cognitive richieste dalla società contemporanea. Questi test, infatti, potrebbero non cogliere appieno le nuove competenze sviluppate in un mondo sempre più digitale e tecnologicamente avanzato.
Il fattore trascurato
C’è un fattore trascurato in tutto questo, sebbene non manchino i campanelli di allarme, lanciati persino dall’Università di Oxford, che segnala sempre minore capacità di lettura e attenzione dei suoi studenti, analogo problema è lamentato dalle università USA, dove gli studenti arrivano quasi incapaci di leggere testi lunghi e articolati. Le università italiane non sono in posizione migliore, e i docenti segnalano la mancanza delle minime basi linguistiche e culturali indispensabili per affrontare la complessità dello studio universitario. È il fenomeno che si chiama ‘analfabetismo funzionale’, cioè persone che nonostante l’istruzione formalmente ricevuta manifestano carenze importanti di conoscenza, preparazione generale, capacità linguistiche e matematiche.
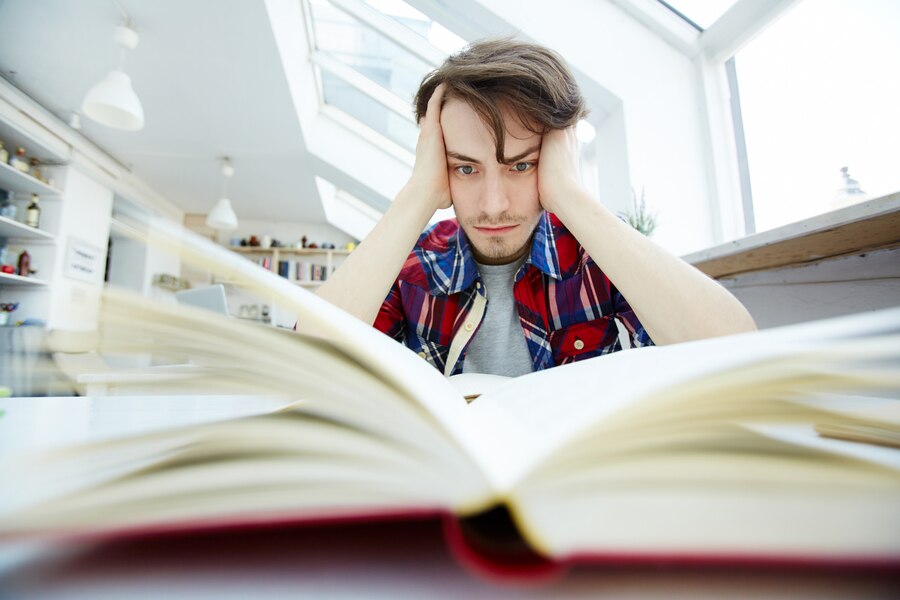
Eppure i programmi scolastici sono stati progressivamente semplificati, ridotti, diluiti, anche banalizzati, ma anziché ottenere una maggiore diffusione di una preparazione minima, resa più comprensibile (che presumibilmente era l’obiettivo) si è ottenuto un incremento dell’analfabetismo funzionale. Fino a giungere all’impensabile: studenti universitari che non solo non sono in grado di comprendere un testo universitario, ma non sanno neanche esprimersi in un italiano da scuola elementare.
Di pari passo alla banalizzazione dell’apprendimento (e probabilmente strettamente connessa) c’è la semplificazione pervasiva del linguaggio.
L’impoverimento del linguaggio, con la riduzione del vocabolario, la semplificazione grammaticale, l’eliminazione delle sfumature lessicali e semantiche, la scomparsa del congiuntivo, delle coniugazioni del futuro e del condizionale, giocano un ruolo fondamentale nel declino cognitivo.
Meno parole, meno possibilità di coniugare i verbi implicano meno opzioni per esprimere le proprie emozioni ed i propri pensieri.
Come costruire un pensiero complesso senza le parole per articolarlo?
Come elaborare un pensiero ipotetico-deduttivo senza il condizionale che formuli l’ipotesi?
Come immaginare un possibile futuro senza una opportuna coniugazione al futuro?
Come descrivere una successione di elementi ed eventi nel tempo, se non c’è la possibilità di distinguere ciò che è stato da ciò che è e che sarà?
Come immaginare ciò che avrebbe potuto essere se gli aventi avessero preso un corso diverso?
Come teorizzare ciò che potrebbe accadere qualora si verificassero determinate condizioni?
Non si possono formulare pensieri critici, complessi e sfumati in assenza di un vasto bagaglio linguistico che consenta di esprimerli. L’assenza espressiva comporta progressivamente anche una difficoltà comprensiva.
È un po’ un circuito vizioso: più il linguaggio si semplifica e meno la mente è in grado di comprendere quello più complesso e avrà bisogno di una ulteriore semplificazione.
Internet, che costituisce un immenso potenziale di sapere diffuso e accessibile, contribuisce all’impoverimento del linguaggio, con gli autori costretti a sottostare alle regole SEO che prevedono standard di leggibilità elementari: frasi corte, paragrafi brevi, poche forme passive, numerosi sottotitoli e riassunti, molte immagini e tante ripetizioni concettuali pur usando sinonimi e guai a stravolgere il canone narrativo imposto di mettere subito la frase chiave nel primo paragrafo… chi osa viene penalizzato dai motori di ricerca. Così soccombono anche i siti di divulgazione scientifica, se non vogliono smettere di essere trovati dagli utenti. Tutto il web appare come erano tanti anni fa i sussidiari dei primi tre anni delle scuole elementari.
Sta scomparendo, drammaticamente sottovalutata anche nelle scuole, la scrittura a mano in corsivo, che richiede concentrazione, attenzione, memoria, presenza e pensiero analitico, tutte attività che affinano le capacità cognitive, a differenza della scrittura digitale, rapida, superficiale e facilmente modificabile. La versione social, poi, contribuisce ulteriormente all’appiattimento linguistico, perdendo completamente la punteggiatura e abusando delle maiuscole, fino a rasentare la totale incomprensibilità.
L’uso smodato di dispositivi digitali, con le loro continue interruzioni e stimolazioni, contribuisce a ridurre la durata dell’attenzione, compromettendo la capacità di concentrarsi su compiti complessi e prolungati, come la lettura di testi impegnativi. Non solo la lettura ma anche la capacità di impegno mentale prolungato risultano compromesse.

La semplificazione progressiva della scuola, dei libri di testo, dei tutorial, del linguaggio stesso, del modo di leggere e scrivere e dell’attenzione sono elementi attivi che non possono non influire sull’impoverimento della mente umana, limitando la capacità di pensiero complesso e critico.
Il calo del QI medio, in questo contesto, non è un dato statistico asettico, ma un campanello d’allarme che segnala un pericoloso declino cognitivo, frutto di una progressiva e preoccupante semplificazione, che probabilmente è anche funzionale, perché somiglia troppo alle strategie di controllo del pensiero narrate da Orwell e Bradbury.