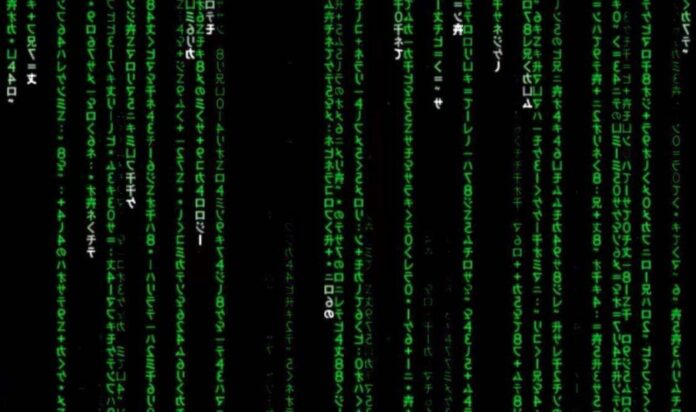di Roberto Daniel Villalba
Restando nella dialettica dei principi e dei fini, e tenendo presente che la felicità – il sommo bene secondo Aristotele – è il raggiungimento del fine virtuoso, analizziamo l’ipotesi di un soggetto che vuole attuare un progetto perché crede (pensa) che ciò lo renderà felice: decide così d’iscriversi ad un corso di Bu-do. Quindi entra in un dojo e inizia l’apprendistato, assumendo come proposito l’idea di diventare una brava (virtuosa) cintura nera; un progetto che quindi prima ha pensato e poi voluto. Persistendo nell’allenamento, tale proposito si cristallizzerà come idea-forza, un combinato di pensiero e volontà. Successivamente però, potrebbe accadere che, incontrando le prime difficoltà, il soggetto abbandoni l’impresa. In tal caso, cosa è accaduto? È difficile stabilirlo con certezza, ma siamo del parere che, fatti salvi gli impedimenti di forza maggiore (salute, famiglia, economia, ecc.), la sua rinuncia sia imputabile all’instabilità del suo temperamento. Tuttavia si fa fatica a stabilire quale fra le componenti del suo “temperamento” ne sia stata la causa; il punto di rottura potrebbe essere stato il mancato rinnovo della sua forza di volontà (pigrizia) o le emozioni negative che l’hanno avvilito (timore, scarsa autostima), o la carenza d’idee precise che chiarissero i suoi tanti “perché”; ragioni che l’avrebbero aiutato a dileguare i suoi dubbi e a persistere nella pratica. Nel primo caso ha difettato la volontà, nel secondo l’emozione e nel terzo il pensiero.
Se un soggetto si “diverte” con la disciplina che ha intrapreso, ma non afferra il senso riposto nei principi e propositi di essa, non capisce tanto quanto un cieco non vede e un sordo non sente: ignora che il solo entusiasmo ludico non gli basterà per superare le difficoltà di routine con cui, immancabilmente, la Via mette alla prova le motivazioni dei praticanti. Un altro invece intende i principi, li ritieni giusti, ma non ha il “gusto” per il modo specifico della disciplina, cioè lui non condivide emotivamente ciò che nel dojo si fa: “capisco, sì, i principi del Ju-do e li apprezzo, ma a me non piace il contatto fisico”. Un terzo intende la filosofia del Ju-do e gradisce la sua pratica; tuttavia non disponendo di una vera, autonoma Volontà, né di una “fantasia” duratura che ne faccia le veci, ossia di un movente esterno che lo stimoli ad impegnarsi, gli mancherà la forza d’animo: la tenacia necessaria per allenarsi con assiduità. In definitiva gli esempi abbondano. Come potrebbero tali individui intraprendere un do con la dovuta serietà? Ciò si capirà ancora meglio da quanto segue.
L’essere umano è un rebus privo di soluzioni uniformi e, come accade con le impronte digitali, va considerato caso per caso; ogni uomo è un esemplare a sé, unico e irripetibile. E tuttavia nonostante la diversità che esiste fra un essere umano e l’altro, essi hanno un comune denominatore: l’irregolarità e la contraddizione fra le funzioni animiche del pensare, del sentire e del volere. Gli esseri umani ordinariamente pensano in un modo, sentono in un altro e agiscono in disaccordo sia con i loro pensieri che con i loro sentimenti. Ciò fa di essi soggetti costantemente cangianti e imprevedibili, ragion per cui è tanto difficile conoscere davvero una persona! Difficoltà a tutti nota, corroborata perfino con l’attestazione di conformità del popolare proverbio cinese人心難測 ren shin nan fùa: “è quasi impossibile sondare la mente umana”. Concordiamo: difficilissimo, poiché nell’individuo corrente ciascuna funzione psichica abusa delle altre a turno, in modo tale che trovandosi in mezzo ad una circostanza (anche banale) una delle funzioni assume lo scettro dell’io e, dicendo “mi piace questa cosa quindi la desidero”, prende un provvedimento per averla; ma all’indomani viene rimossa da un’altra funzione che, in disaccordo con le decisioni della prima, si pente e dice: “io penso d'essermi sbagliato” e dirotta tutta la persona in una direzione opposta. Badate bene: si ha a che fare con determinazioni prese da funzioni discordanti che tuttavia parlano, una alla volta, a nome di tutta la persona! La radice dell’infelicità è proprio qui: nell’instabilità e nell’imprevedibilità dell’essere umano che, di conseguenza, proietta la sua disarmonia nell’esterno, promuovendo il caos attorno a sé. Per questa ragione è imprescindibile l’accordo delle funzioni psicologiche con cui l’uomo si inserisce nelle tre dimensioni che il mondo gli ha assegnato come sue. L’asse, il trait d’union che allinea le funzioni interne con le dimensioni umane preposte all’ interazione con il mondo è il lavoro interiore che porta l’io reale a insignorirsi, ad imporsi sullo stato di anarchia dilagante nell’anima. Un’avventura della coscienza operata dall’io, per la rinascita dell’io. Per la genesi dell’io vero s’intende, non dell’ego. In ciò consiste la possibilità – esclusiva dell’uomo attuale – di vedere nitidamente, obiettivamente, ciò che in realtà egli è; cioè di prenderne coscienza per poter agire volontariamente sulla realtà interiore, a patto che in lui una vera volontà ci sia… Si ha che fare, in tal senso, con un processo evolutivo in cui nessun incentivo viene ulteriormente concesso dalla Natura, ma che l’uomo per propria iniziativa può dapprima attivare e in seguito persino sviluppare, avvalendosi però di una determinazione incrollabile. Un processo giustamente definito epigenetico. Parliamo in parole povere di ciò che l’uomo non può avere dalla Natura: cioè autocoscienza e volontà reali, requisiti indispensabili di quella autoconoscenza a cui, seppur rinnegandola, egli inspiegabilmente tende. Concetti che man mano chiariremo nel corso della lettura.
Parimenti alle tre dimensioni spaziali che vengono raffrontate con il tempo (considerato la quarta dimensione), l’autocoscienza o coscienza che l’io ha di se stesso è in realtà il tempo psicologico che rapporta e unifica le tre possibilità dell’agire umano nel mondo: il “fare” intellettivo, il “fare” sensitivo e il “fare” volitivo. A queste dimensioni esistenziali rispondono le tre funzioni psicologiche dell’io: pensare, sentire e volere. Torneremo volentieri su tale assunto nel 9° capitolo. In ogni caso, ora siamo in grado di sviscerare le dimensioni umane elencate da Aristotele già nel lontano IV sec. a.C. (!)
La dimensione razionale-cognitiva è l’ambito della filosofia e della scienza. Essa si attua nel pensiero e il suo termine (suo fine) è la contemplazione della verità: theorein in greco classico, che proviene dal verbo theoreo (“io esamino”, “osservo”) e declina in theoria (dottrina).
La dimensione creativa, che è binaria, perché ha due radici (le punte dell’allegorico “arco” di cui prima dicevamo):
a) il fare / produrre (poièin), che viene dal verbo poìeo (“io creo”) e declina in poìesis, l’atto poetico (“poesia”) che risulta nella creazione dell’opera bella (poièma);
b) l’arte (tèchne) nell’accezione di “tecnica”, che è dal verbo tìkto (“io produco”), corrispondente al concetto di “come fare” qualcosa nel migliore dei modi, dunque “l’arte” riferita al gesto esemplare di riprodurre alcunché di pratico; ma anche di produrre da sé l’inedito, qual è il caso dell’invenzione o della scoperta; quindi di “creare” in senso lato la cosa necessaria, l’oggetto utile al miglior vivere.
È da notare che tanto l’arte strumentale (tò technikòs) al fine pratico, cioè la tecnica (tèchne), quanto l’attività creatrice (é poiètiké) ispirata dall’idea di produrre il bello (poièin), sono state ugualmente tradotte in latino come “arte” (ars), e ciò portò a confondere la produzione creativa – l’arte vera – con la produzione utilitaria del “come fare” – la tecnica –, comunque inizialmente creativa, ma che in seguito diventa imitativa e, infine, meccanica. A questa classificazione aristotelica vogliamo aggiungere che l’ambito creativo era per gli uomini antichi, come lo è tuttora per noi, il territorio naturale delle emozioni ordinarie e dei sentimenti superiori, forze animiche che mobilitavano l’ingranaggio dei rispettivi compartimenti: uno utilitaristico, finalizzato al conseguimento dei risultati pratici (la tecnica), quasi sempre dettato dalla necessità; l’altro propriamente spirituale (l’arte), esternazione della libertà dell’uomo. Tuttavia, in ogni caso, ambedue destinati a concretizzarsi in azioni e opere indistintamente esterne, utili e/o belle. Azioni e opere (oggetti) che denotano l’agire con cui l’uomo modifica il mondo, che perciò vanno incluse nel significato generico di “creare”, che è dal greco kraìnò¹.
La dimensione morale o etica (praxein). Il suo atto è la praxis (“la giusta azione”) e la sua finalità è la bontà, la perfezione interiore del soggetto. Per Aristotele il campo della prassi includeva l’etica, l’economia e la politica. La facoltà specifica dell’atto morale (o “pratico” in senso classico) è la volontà, l’elemento agente, potenza dello spirito che, unitamente alla coscienza, è espressione della libertà dell’uomo. La facoltà volitiva si attua oggettivamente nell’intenzione di compiere deliberatamente l’azione giusta, ossia nel voler fare ciò che la coscienza sostiene debba essere fatto, che è il bene impersonale: far del bene per il bene stesso; invece soggettivamente, la volontà si dà nel cercare il perfezionamento personale, che si concretizza in virtù. In altre parole, la volontà è sempre e solo volontà del bene, restando altresì una qualità intrinseca e autonoma dell’io: virtù.
Per cui la volontà è il principio energetico, intimo e intrasferibile dell’io o, per meglio dire, non trasfondibile: l’io non accetterebbe una volontà che gli fosse “installata” dall’esterno alla stessa stregua di un trapianto d’organo. La deve scorgere in sé e poi svilupparla. Fare propria una volontà altrui sarebbe un’intrusione che egli non accetterebbe mai, perché ciò lo annullerebbe in quanto io. Siccome prima d’ogni altra cosa l’io vero è il costrutto di una coscienza di sé e di una volontà propria, non presa in prestito o ricevuta in dono, il soggetto non potrebbe osar dire “io voglio”; non disponendo di una sua originaria e autonoma volontà, egli non potrebbe esercitarsi nell’uso del libero arbitrio… E non essendo libero di scegliere e decidere da sé non sarebbe degno di autoproclamarsi “io”. Per lo stesso motivo i dettami della volontà non devono essere confusi con le pulsioni delle passioni (volere non è desiderare) né con gli impulsi ciechi degli istinti, giacché essi non provengono dall’io, anzi lo escludono.
1) In riferimento all’agire creativo dell’uomo nel mondo, si noti che la parola latina “creare” – nel senso generico del fare – proviene del greco kraìnò: (io) “creo”, “produco”, “compio”, che a sua volta discende dal sanscrito karoti करोति (fare), cui radice kr कृ è la stessa di kriya क्रिया “atto” e di karma कर्म “azione”, “attività”.
Fonte: estratto dall'opera Bu-do esoterico. La dimensione interiore delle Arti Marziali Orientali (Nexus Edizioni, 2018).
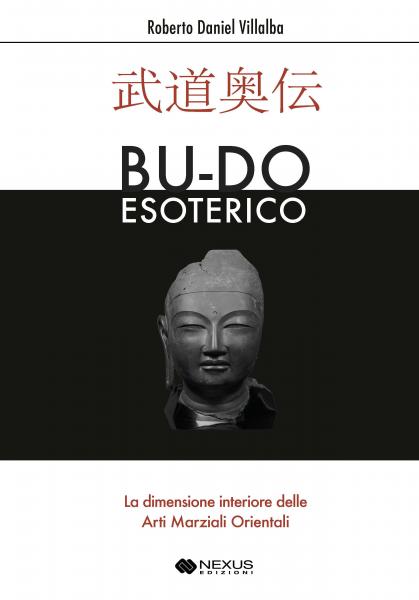 Quest’opera, unica nel suo genere, riempie il senso di vuoto che accomuna i molti amanti delle Arti Marziali, poiché svela il messaggio originario che i saggi orientali hanno lasciato a noi cittadini della globalizzazione: il Bu-do 武道, la Via alternativa all’incalzante processo di disumanizzazione in corso. Tale messaggio è volutamente travisato dal Sistema consumistico, per cui la stragrande maggioranza dei praticanti – esperti compresi – non ne è a conoscenza.
Quest’opera, unica nel suo genere, riempie il senso di vuoto che accomuna i molti amanti delle Arti Marziali, poiché svela il messaggio originario che i saggi orientali hanno lasciato a noi cittadini della globalizzazione: il Bu-do 武道, la Via alternativa all’incalzante processo di disumanizzazione in corso. Tale messaggio è volutamente travisato dal Sistema consumistico, per cui la stragrande maggioranza dei praticanti – esperti compresi – non ne è a conoscenza. L’arte del Bu-do affonda le sue radici nelle filosofie orientali del taoismo e del buddhismo. La sua pratica inizia dal corpo (wai-kong: lavoro esterno) per poi equilibrare e potenziare la mente (nei-kong: lavoro interno) cosicché, agendo insieme, essi possano ridestare nell’umano la percezione del divino (shen-kong: lavoro spirituale).
L’uomo d’oggi, costretto ad una lotta impari contro materialismo e scientismo dilaganti, troverà giovamento nel rimettersi in marcia sulla strada meno battuta, l’ormai dimenticata Via interiore.

Roberto Daniel Villalba nasce a Buenos Aires nel 1950. Iniziato alla pratica dello yoga e delle arti marziali a 15 anni, nel 1969 ottiene la cintura nera 1° Dan di Judo. Nel 1971 raggiunge il 1° Dan di
Taekwon-Do. Ha iniziato ad insegnare Judo e TKD nel prestigioso Istituto Vecchio di Mar del Plata nel 1970. Nel 1974 viaggia negli USA per perfezionarsi nel Tang Su Do, stile di karate coreano, che nel 1977 introduce in Italia. Nel 1984 è promosso 1° Dan di Kendo. Nel 2009 gli viene conferito onorificamente l’8° Dan di TSD. Laureato in Filosofia Classica presso la Pontificia Università Lateranense, specializzato in Orientalismo e in Scienza delle Religioni, ha inoltre compiuto studi di Antropologia Archeologica presso l’Università Nazionale di Mar del Plata. Con la casa editrice Edizioni Mediterranee ha pubblicato due libri sul Tang Su Do (1991 e 1994).